
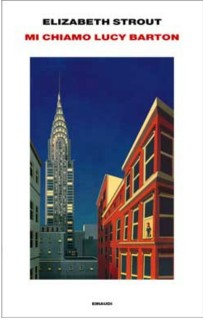 Qual è il romanzo perfetto? La domanda, posta in termini assoluti, non avrebbe senso. Il romanzo perfetto, in cruda sostanza, è quello che riesce a piacere a più persone possibile. Per dirla in semiotica: che sappia prevedere un numero assoluto di lettori modello, così da appagare chi è in cerca di una storia, magari d’amore, chi vuole evadere dal quotidiano, sognando la vita altrui e chi, tra le pagine di un libro, cerca davvero il senso della vita.
Qual è il romanzo perfetto? La domanda, posta in termini assoluti, non avrebbe senso. Il romanzo perfetto, in cruda sostanza, è quello che riesce a piacere a più persone possibile. Per dirla in semiotica: che sappia prevedere un numero assoluto di lettori modello, così da appagare chi è in cerca di una storia, magari d’amore, chi vuole evadere dal quotidiano, sognando la vita altrui e chi, tra le pagine di un libro, cerca davvero il senso della vita.
“Mi chiamo Lucy Barton“, ultima opera della statunitense Elizabeth Strout, già premio Pulitzer con una raccolta di racconti (Olive Kitteridge), chiariamolo subito, non fa nessuna delle tre cose. Eppure è un romanzo perfetto. Certificato di garanzia, in questo caso, è il fatto che il giudizio arrivi da un numero innumerevole di fonti: i lettori americani e italiani, per dire, così diversi tra loro. Oppure gli amanti di generi cerebrali, più riflessivi, ma anche gli amanti di un mondo più pulp.
Il primo dei due universi è un vecchio e fetido garage, abbandonato nella periferia agricola di un buco nero della sterminata provincia americana, Amgash, Illinois. In quella casa, si fa per dire, si svolge la vita ai margini di una ragazzina, che i compagni ignorano perché puzza di povertà, non si sa vestire, e ha una strana famiglia al seguito. Il secondo mondo è quello in cui si svolge il libro: New York. Bella, pulita, asettica eppure così piena di vite, storie, stimoli e miti.
Lucy Barton è tutti e due quei mondi. Il primo è quello della sua infanzia. Il secondo quello del presente, in cui la donna – giovane scrittrice in erba -, si ritrova per due mesi a causa di un’infezione in una camera d’ospedale, lontana da suo marito e dalle sue due figlie, e da quel mondo luccicante della Grande Mela là fuori, che l’ha affascinata al suo arrivo e che continua ad attrarla.
La malattia è una bestia strana: è in grado di aprire gli occhi alle persone per costringerle a guardare quanto è bella la vita quotidiana che fino a un giorno prima disprezzavano. Questo, però, non è affatto un libro di malattia e dolore. E’ il libro di una camera d’ospedale, questo sì. E di una donna fuggita dal suo passato di povertà a suon di buoni voti, che ai margini di quel suo letto d’ospedale vede spuntare, d’improvviso, la madre che non è venuta al suo matrimonio, che non conosce le sue nipoti e che da piccola non l’ha mai baciata.
Brutta storia, anzi, bellissima. Perché nel dialogo tra le due che si instaura non c’è nulla davvero malinconico o pietoso. ‘Mi chiamo Lucy Barton’, fatte salve tutte le premesse, è un libro divertentissimo. Pieno di vita vera, non surrogata dai ricordi o le speranze di un malato. Vita concreta, vissuta senza lustrini o poster patinati (ci starebbero, ché gli anni in questione sono gli Ottanta), vita di rabbia e di azioni concrete. Ricordi d’infanzia lasciati a macerare sotto gli strati più profondi dell’anima. Cose indicibili che, poi, indicibili non sono affatto. Amori e tradimenti, veri o presunti. Pettegolezzi, questo sì, perché cos’è poi un romanzo, se non insinuarsi per un poco nella vita altrui?
Ma ci vuole stile a farlo, e questo è il punto. E di stile, queste pagine, sono scolpite. In questo di sicuro c’è perfezione. Elizabeth Strout sa costruire le sue frasi, sa descrivere i silenzi, emozionare coi sentimenti, senza cedere mai al fascino facile dell’aggettivo inutile. Una storia fatta di cliché (la Grande Mela, la provincia americana, la malattia, il rapporto ritrovato tra madre e figlia e vagonate di altre consuetudini), ma che nel cliché riesce a non scadere mai.
Nessuna frase è inutile o fuori posto. Nessuna indulgenza è mai chiesta al lettore: il libro è perfetto, e di perfezione può soltanto stupire, lasciando attorno a sé, dopo la lettura, la sensazione che di quel tempo speso troveremo un senso, e che un’impronta di quelle parole da qualche parte resterà appiccicata, pronta a ricreare la sensazione di aver amato Lucy Barton e la bellezza della sua storia. Vivaddio, ogni tanto succede ancora.
© Riproduzione riservata